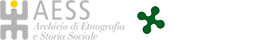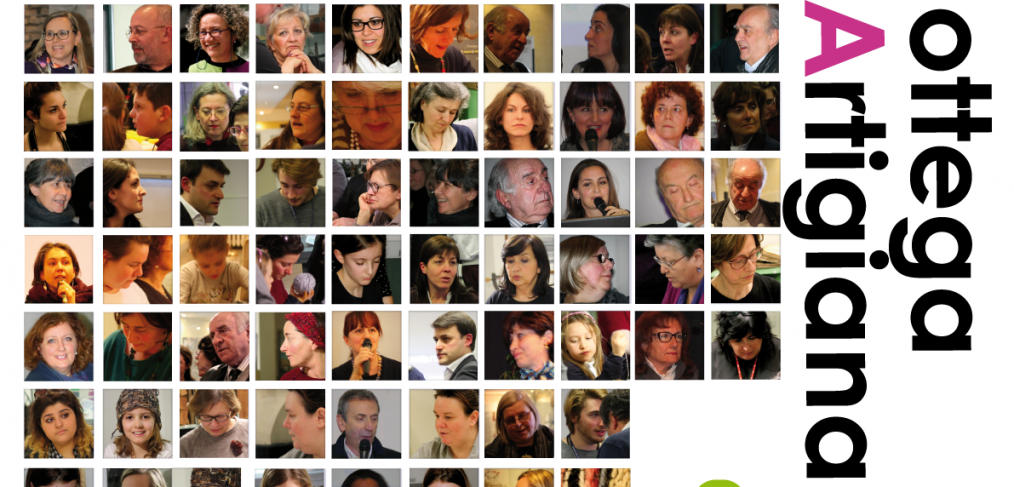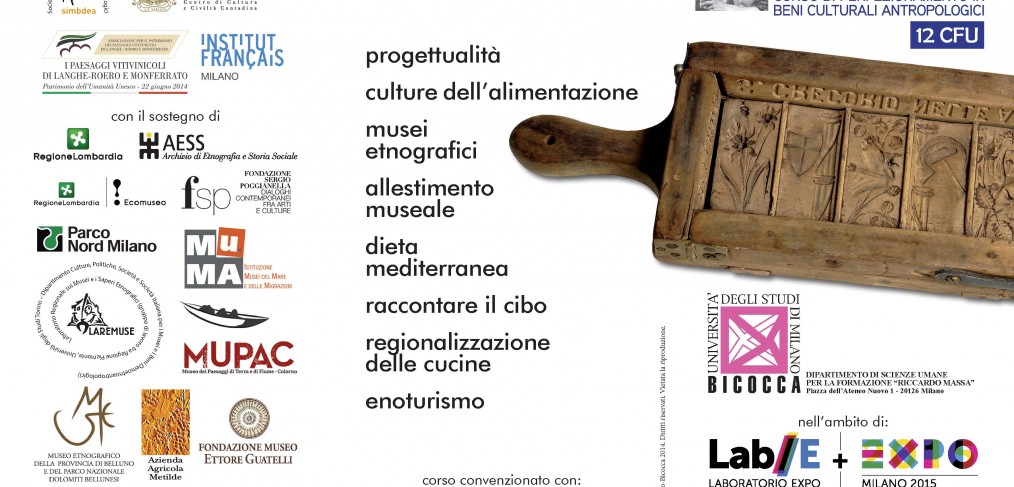Il progetto “Design al Tombolo”, finanziato da E.CH.I. all’interno delle attività di promozione creativa dei territori e dei loro patrimoni immateriali, continua a suscitare interesse!
Le borse transfrontaliere progettate da sei designer del Politecnico di Milano in collaborazione con la comunità di merlettaie al tombolo di Cantù, saranno ospitate al Museo del Tessile e della Tradizione Industriale di Busto Arsizio (VA).
L’iniziativa è di Bottega Artigiana, un contenitore di progetti nato per promuovere la conoscenza degli antichi mestieri e l'arte artigiana italiana, attraverso mostre, laboratori, dibattitti. Tema dell’esposizione e della tavola rotonda è:
“Progetti, intenzioni, storie e notizie del mondo tessile”.
A seguito della tavola rotonda debutterà l'evento “Lacing Show: performances itineranti di merletto al tombolo”, organizzato dal Comitato per la Promozione del Merletto di Cantù e patrocinato da E.CH.I. Un circuito di eventi nella città di Milano finalizzati a promuovere il lavoro delle merlettaie all’opera per la realizzazione di 4 tovaglie in merletto disegnate da famosi designer: Patricia Urquiola, Luca Scacchetti, Alessandro Mendini, Ugo La Pietra. La “tovaglia in merletto” diventa occasione per interpretare il tema di EXPO2015 attraverso un elemento del corredo protagonista “prezioso” delle ritualità di consumo e condivisione del cibo in Italia.
Programma
Busto Arsizio 13 marzo 2015
Museo del Tessile e della Tradizione Industriale
Via Alessandro Volta 6/8 15.00 17.00
Tavola rotonda sul tema:
“PROGETTI, INTENZIONI, STORIE E NOTIZIE DEL MONDO TESSILE”
Interverranno:
Renata Casartelli, Presidente del comitato per la Promozione del Merletto di Cantù
Alberto Cavalli, Presidente di Fondazione Cologni : I mestieri d’arte alla radice dell’eccellenza italiana
Ugo Crespi, docente di tecnologia tessile ,Associazione ex allievi e sostenitori Itis Busto Arsizio
Pino Grasso, maestro d’arte: Storytelling
Ilaria Gugliemetti, designer: Design al Tombolo. Progetto di un intreccio. Un’ azione di valorizzazione promossa da E.CH.I.
Paolo Pianezza, imprenditore: Storytelling
Ilario Tartaglia, ingegnere tessile: La tessitura a mano: la tessitura a mano può giocare ancora un ruolo nel XXI secolo, nell’era della robotica?
Modera il dibattito la giornalista Carla Tocchetti
A seguire:
“Lacing Show: performance di merletto al tombolo di Cantù”
Bottega Artigiana Facebook